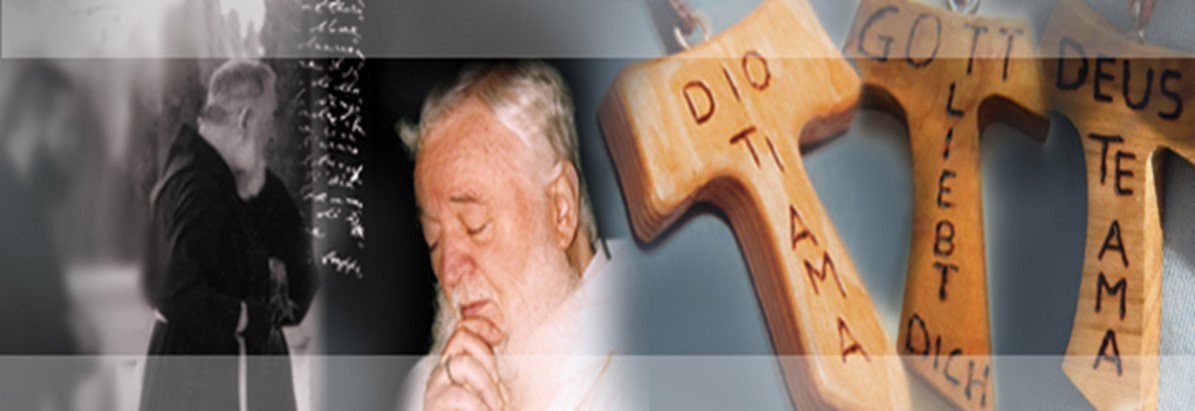PREPARAZIONE AL SINODO OBLATI 2017 - ANNO I
“Fraternità e missione”
Sintesi revisionata delle relazioni redatte dagli Oblati di tutte le case, a cura della Commissione Generale per il Sinodo degli Oblati 2017.
Cella di Noceto (PR) , 18 - 19 settembre 2016
Introduzione
Il Signore ci ha fatto il dono di chiamarci a far parte di una fraternità francescana, famiglia allargata a cui siamo inseriti come oblati e abbiamo bisogno di domandarci sempre se “siamo veramente uniti gli uni con gli altri, se sussiste in noi quell’unità che Gesù ha offerto ai suoi, tramite il dono dello Spirito Santo”.
L’elemento fondamentale che costituisce lo “Spirito fraterno di famiglia” è l’unità. L’unità, pietra angolare della fraternità fra i cristiani, caratterizza la nostra Fraternità Francescana di Betania, così come ha sempre sostenuto il nostro fondatore padre Pancrazio. La fonte autentica di ogni unità è Cristo che l’ha offerta a noi tramite il dono dello Spirito Santo.
L’unità nella diversità dei caratteri ha il suo fondamento in questa visione di fede: “Dio mi ha fatto dono del fratello che è, per natura e per volere divino, diverso, altro. Partendo da questa visione non possiamo privilegiare un fratello in detrimento dell’altro, non possiamo escludere nessuno a causa della sua diversità. I fratelli non si scelgono come gli amici, ma si ricevono come un dono.” (fr. Iosè Rodriguez).
Siamo coscienti che la costruzione di uno spirito di famiglia nei nostri gruppi è un impegno non facile per le tante difficoltà, il poco tempo che ci rimane dai nostri impegni quotidiani e le nostre fragilità con cui dobbiamo fare i conti ogni giorno. Impegniamoci per quanto ci è possibile e il resto lo farà il Signore e la sua dolcissima madre Maria a cui ci rivolgiamo con la bellissima preghiera formulata dal nostro Padre Pancrazio:
Oh Maria, Madre dolcissima dell’Amore fattosi uomo in mezzo a noi, tu che hai permesso che lo Spirito Santo compisse in te mirabile prodigio della tua totale unificazione con la volontà del Padre, e lo rinnovasse ogni giorno della tua vita sino a condurti sotto la croce di tuo Figlio, proprio per quel suo comando che ti fece Madre immacolata di noi poveri peccatori, provvedi ad unificare i nostri cuori rigenerati dal sacrificio di Gesù, affinché possa risplendere anche in questa Fraternità la meravigliosa bellezza dell’opera della redenzione che ci rende una cosa sola con Lui. Amen.
1. Fraternità e missione
1.1. Nella Vita Di Gesù
Il desiderio di Dio è inserito nel cuore dell’uomo, perché l’uomo è stato creato da Dio e per Dio e il Creatore stesso non cessa di attirare a sé l’uomo; soltanto in Dio infatti l’uomo troverà la verità e la felicità che cerca senza posa. Per una decisione del tutto libera Dio si rivela e si dona all’uomo svelando il suo disegno di benevolenza prestabilito fin dall’eternità in Cristo a favore di tutti gli uomini. Egli rivela pienamente il suo disegno inviando il suo Figlio prediletto, il Signore nostro Gesù Cristo e lo Spirito Santo. La rivelazione soprannaturale culmina nella Persona e nella missione del Verbo fatto Carne: Gesù Cristo.
La prima comunità in cui Gesù è vissuto è stata la sua famiglia, quindi Maria, Giuseppe, i parenti e la piccola realtà della città di Nazareth, in Galilea: vita di fraternità caratterizzata da atteggiamenti di profonda fede e preghiera al Padre, sottomissione e docilità alla Sua volontà riconosciuta come bene sommo per la vita di ciascuno di essi e per l’umanità intera. Egli passò la sua gioventù a Nazareth, lavorando come falegname accanto a Giuseppe.
Quando i tempi furono maturi, Gesù cominciò a svolgere la sua missione di evangelizzazione e diffusione del Vangelo. L'evangelista Marco presenta il messaggio di Gesù con una frase sintetica che riassume il contenuto della sua missione: "Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al Vangelo" (Mc 1,15).
Gesù quindi inizia la sua missione venendo in mezzo a noi e facendosi obbediente, “non ritenendo un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliando se stesso, assumendo la condizione di servo”. Mite e umile di cuore, annunciò la buona notizia: “Il regno di Dio è in mezzo a voi”.
Questa missione affidata dal Padre al Figlio inizia con il battesimo di Gesù nel Giordano, quando una voce celeste lo riconosce come il Re e Messia. A Gesù viene quindi affidato il compito di annunciare il Regno di Dio per la felicità e la salvezza di tutti gli uomini e Gesù ci rivela questo regno oltre che con la Parola, con la sua Passione e croce. Con la sua passione ci fa capire che nessun esempio di virtù è esente dalla croce. Sulla croce ci dà il più grande esempio di carità e amore: “Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici”; sulla croce ci dà un esempio di pazienza: “Quando soffriva non minacciava”. Veniva schernito, sputacchiato, percosso, coronato di spine eppure è rimasto obbediente al Padre, fino alla morte; ha detto no agli onori, no alle ricchezze, no ai piaceri.
Gesù annuncia che Dio, in quanto Re dell'universo, entra direttamente nella storia dell'uomo e la trasforma dal profondo.
Nella persona stessa di Gesù, Dio è all'opera per cambiare il mondo. Questa è la buona notizia. Di fronte ad essa ognuno deve cambiare mentalità, fidarsi di questa parola ed accoglierla con entusiasmo.
Il suo stile è quello della valorizzazione di ogni persona, anche di chi è debole e insignificante, come una canna spezzata, o uno stoppino che sta per spegnersi. Il riconoscimento del valore positivo, che è presente in ogni persona, è il metodo missionario di Gesù.
La figura del "Servo" mette in risalto la solidarietà di Gesù con i malati e i peccatori, la sua con-divisione e la sua com-passione: autentico missionario, egli si è messo dalla parte degli ultimi e li ha liberati soffrendo con loro (Mt 12,15-21).
Lui voleva mostrare la volontà di essere fratello universale di tutti, giusti e ingiusti, ricchi e poveri, credenti in Dio e pagani.
1.2. Nelle Prime Comunità Cristiane
Durante la vita di Gesù, l’ambito della missione degli apostoli è delimitata a Israele, i destinatari sono gli stessi del Gesù pre-pasquale, Re e Messia di Israele (cfr. 15,24), ma dopo la sua morte e risurrezione Gesù risorto, costituito Messia e Signore universale, invierà i suoi in tutto il mondo (cfr. 28, 18-20). Gesù disse loro (agli Apostoli): “Andate in tutto il mondo, predicate il vangelo a tutta la creazione. Chi crederà e sarà battezzato, sarà salvo; chi non crederà sarà condannato” (Mc 16,16).
La missione quindi cambia profondamente, e segna una novità assoluta nell’apertura missionaria, rendendo possibile ed effettiva la missione apostolica, accompagnata dal dono dello Spirito Santo.
Nel piccolo cenacolo con gli Apostoli e alcune donne, fra le quali Maria la madre di Gesù, prese vita la prima Chiesa. Gli apostoli (=inviati) predicano che la risurrezione di Gesù è l’inizio del compimento del Regno di Dio annunciato da Gesù stesso. Pietro, a cui il Signore dice “Pasci le mie pecorelle”, si presenta come il capo riconosciuto delle comunità, e con lui spiccano Giacomo e Giovanni: insieme formano “LE COLONNE “, come li chiamerà San Paolo (Gal 2,9).
Ma come vivevano i primi cristiani? Ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane a casa prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo (Atti 2, 42).
Così nutriti continuamente della Parola di Dio, molti decisero di condividere i propri beni a vantaggio dei poveri: infatti quanti possedevano campi o case le vendevano, portavano l’importo di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli Apostoli e poi veniva distribuito secondo il bisogno di ciascuno.
Alla regola del “mio” e del “tuo” si sostituiva così la condivisione e la solidarietà, annullando, con la vera comunione, ogni differenza sociale.
I primi cristiani pregano insieme nel tempio e nelle case; è sempre lo Spirito che prega in loro e fa sentire la sua potenza. La moltitudine dei credenti aveva un cuor solo e un’anima sola.
1.3. Nella Prima Comunità Francescana
San Francesco ci riporta continuamente al Vangelo, da cui egli non toglieva mai lo sguardo, non tanto come testo scritto, ma come testimonianza vivente della vita e delle parole di Gesù, di cui era innamoratissimo.
Dio è “Il Vivente” da cui tutti i viventi hanno origine. San Paolo ci dice con semplicità che tutti gli uomini possono giungere alla sua conoscenza, scoprirlo, ammirando le bellezze della creazione (Rm 1), quella creazione tante volte cantata dal nostro San Francesco. Egli chiamava il sole fratello, la luna e le stelle sorelle, come anche il vento, il fuoco, così anche i vegetali e gli animali. Lo faceva perché aveva compreso che abbiamo un solo Padre che ama il cosmo, opera delle sue mani, di cui noi siamo la corona. Sentiva tutto come fratello e sorella a motivo di questa magnifica paternità con la quale Dio Padre, l’Altissimo, ha creato ogni cosa. Ama il passaggio da creatore a padre, è un dono di rivelazione fatto a noi da Gesù. È lui che per primo chiama Dio con il termine di Padre, non padre-padrone ma Abbà, papà, invitando anche noi a chiamarlo così.
Ma noi sappiamo che la Trinità (Tri-Unità) delle persone divine non significa tre divinità. Non sono tre individui, tre individualità, tre isole, ma tre persone talmente concordi e unite nella comunione da essere una cosa sola.
In questo senso possiamo affermare che Dio non ha relazioni ma è relazione, da qui la comunione. Dio non fa comunione, ma è comunione.
Non si può parlare di fraternità, di comunione, senza comprendere profondamente queste realtà.
Francesco d’Assisi ci ammaestra con la sua stessa vita. Il suo esempio e le sue parole, semplici e dirette, ci indicano la via: mettere i propri piedi sulle orme del Maestro.
Nel suo Testamento del 1226, il poverello di Assisi ci comunica in modo lapidario che i fratelli e le sorelle sono un DONO, che egli ha ricevuto da Dio. Con tutto quello che un dono comporta. Dietro un dono c’è amore, c’è premura, ma anche richiesta di custodia, infatti è un dono di cui non si diviene proprietari.
Ma ascoltiamolo dalla sua viva voce: “E dopo che il Signore mi donò dei fratelli, nessuno mi mostrava che cosa dovessi fare, ma lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del santo Vangelo.” FF 116
Dal testo appena letto vediamo che Francesco lega il dono dei fratelli con la chiamata a vivere secondo il Vangelo. Questo stretto legame ci ammaestra. Siamo chiamati a vivere il Vangelo anzitutto nella relazione coi fratelli.
È nella comunione che Gesù si fa presente, con certezza: “Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro” (Mt 18, 20).
Possiamo dire in tutta tranquillità che Francesco mette nella sua vita, prima di se stesso, il fratello bisognoso (i lebbrosi, i mendicanti, le vedove, i bambini, gli ammalati, i fratelli di comunità). Nelle fonti francescane si legge spesso che Francesco, assorto in contemplazione, non esitava un momento a lasciare la preghiera per soccorrere quanti lo chiamavano. La gente che lo incontrava aveva la netta sensazione che Cristo stesso fosse tornato a calcare con i suoi piedi la nostra povera terra.
Per il Santo più popolare d’Italia la parola “missione” torna al suo senso originario. Egli non aggiunge niente di quanto già contenuto nel battesimo. Essendo il Vangelo al centro del cuore di Francesco (non è un caso che venga molte volte rappresentato nell’atto di stringersi il Vangelo al petto) non fa altro che riscoprire l’invio che Gesù diede agli apostoli prima e ai settantadue discepoli dopo.
E’ bene ricordare che Francesco comprende finalmente la sua vocazione quando entrando nella chiesetta della Porziuncola ascolta la proclamazione del Vangelo di come gli apostoli dovessero andare in missione.
Per Francesco andare in missione significa portare le parole e gli esempi di Gesù agli altri, prima di tutto con l’esempio e poi eventualmente con la parola. Una parola che chiama alla penitenza, intesa come conversione.
1.4. Nella Vita Del Cristiano
Dio è comunione, perciò Egli ci chiede di entrare in intimità con lui. La nostra vocazione è entrare in comunione con lui; noi per il peccato ne siamo usciti.
Entrare in comunione con Dio e con i altri uomini suoi fratelli è la più alta vocazione dell’uomo. Questo disegno di Dio e stato compromesso dal peccato che ha frantumato ogni tipo di rapporto: tra il genere umano e Dio, fra l’uomo e la donna, tra fratello e fratello, tra i popoli, tra l’umanità ed il creato.
L’amore del Padre ha mandato il Figlio suo perché annunciasse la fraternita universale. Ha insegnato l’uguaglianza e la riconciliazione nel perdono capovolgendo i rapporti di potere e di dominio.
Il Padre donandoci lo Spirito Santo ha realizzato l’unita voluta da Cristo. Un cuore solo, un’anima sola. Dobbiamo amarci come Gesù ci ha amato.
La missione per il Cristiano rappresenta il mezzo di santificazione e per tanto, è una esigenza.
Il Cristiano trova il mandato missionario in Mt 28, 19-20.
Il fine ultimo della missione è quello di rendere partecipi gli uomini della comunione tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. La via della missione è Cristo.
Quindi ogni laico, in ragione degli stessi doni ricevuti, è un testimone e insieme uno strumento vivo della missione della Chiesa stessa, secondo la misura del dono di Cristo.
1.5. Nella Vita Dei Nostri Santi Protettori
1.5.1 San Giuseppe
San Giuseppe è testimone di vita fraterna perché ha creato con Gesù e Maria, per mezzo del vincolo della carità una comunità domestica in cui circolavano la paternità pienamente vissuta, l’ascolto, la tenerezza, la comprensione e l’attenzione al vero bene dell’altro. Quanti insegnamenti da ciò derivano oggi per la famiglia! E’ nella “Santa Famiglia”, in questa originaria “Chiesa domestica”, che tutte le famiglie cristiane debbono rispecchiarsi. In essa, infatti, “per un misterioso disegno di Dio è vissuto nascosto per lunghi anni il Figlio di Dio: essa, dunque, è il prototipo e l’esempio di tutte le famiglie cristiane” (“Familiaris Consortio”, 85).
San Giuseppe è stato chiamato da Dio a servire direttamente la persona e la missione di Gesù, mediante l’esercizio della sua paternità cooperando al grande mistero della Redenzione. La sua paternità si è espressa concretamente “nell’aver fatto della sua vita un servizio, un sacrificio, al mistero dell’incarnazione e alla missione redentrice che vi è congiunta, nel fare alla Sacra Famiglia, totale dono di sé, della sua vita, del suo lavoro e nell’aver convertito la sua umana vocazione all’amore domestico nella sovrumana oblazione di sé, del suo cuore e di ogni capacità nell’amore posto al servizio del Messia germinato nella sua casa” (“Insegnamenti di Paolo VI”, IV [1966] 110).
1.5.2 Santa Marta, Maria e Lazzaro di Betania
L’amicizia che lega Marta, Maria e Lazzaro a Gesù è quell’esperienza da incarnare nelle nostre vite … là dove la quotidianità si intreccia di relazioni, avvenimenti, difficoltà e traguardi.
Vivere a Betania è stare in ascolto della Parola, è accogliere la vita in tutte le sue sfumature e contesti, è misericordia e carità nelle gioie e nei dolori, è pace e riposo dell’anima e del corpo.
Gesù riposava a Betania, e quell’esempio di vita ci indica gli equilibri da mantenere per poter vivere serenamente e in abbandono a Dio, fidandosi della Sua Parola, assaporando il dolce vivere di quei momenti gioiosi trascorsi nella vera e sincera amicizia.
La vita di Betania si trasforma quindi in un modello di vita da seguire e da diffondere, la Chiesa domestica, dove Gesù vive e dà vita («Lazzaro, vieni fuori» (Gv 11,43), ci rigenera, ci rialza dalle nostre morti interiori e ci garantisce la risurrezione dell’anima e del corpo.
Nell’oscurità del mondo, nella fatica del cammino… Marta ci dice “Si, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve venire nel mondo” (Gv 11,27).
Nel silenzio del quotidiano e dell’ordinario Gesù a Betania indica la straordinarietà del vivere con Lui, la missionarietà di uno stile di vita attuale e futuristico: Parola di vita eterna.
1.5.3 San Pio da Pietrelcina
La storia di Padre Pio è la storia di un amore profondo e fecondo per Dio e per l’umanità, della sua attenzione verso chi soffriva, il suo amore per la giustizia.
La sua conformazione a Cristo si rende evidente nelle Stimmate che il Signore gli ha donato. E’ dal cuore di Cristo che attinge la sua dedizione al sacramento della riconciliazione.
La sua missione era ascoltare, comprendere, aiutare, proteggere e pregare per i fratelli che si recavano da lui per chiedere conforto, convinto com’era che il più grande tesoro da dare all’umanità è Dio.
Tutto questo non gli impediva, nella vita di tutti i giorni, di svolgere i servizi e i lavori ordinari e anche straordinari, ricordando sempre l’importanza delle piccole cose.
San Pio, accettò sofferenze, restrizioni e dolorose solitudini sempre confortato nell’intimità con Dio, dalla preghiera, dall’ubbidienza e da una condotta di vita francescana esemplare.
Egli volle fortemente un’opera che fosse segno di amore per i poveri e i sofferenti la “Casa Sollievo della Sofferenza”: dietro suo desiderio si formarono numerosi i “Gruppi di Preghiera” che si sono diffusi in tutto il mondo, facendo amare questo perfetto figlio di San Francesco.
1.5.4 Don Tonino Bello
Ecco come rispondeva Don Tonino alla domanda: “Chi può essere missionario oggi?”
“Missionario è chiunque sia appassionato di Gesù, della Chiesa e dell’uomo ed abbia il cuore grande come il mondo. Non conta dove si è e per dove si parte. Missionario è chiunque si fa scompaginare l’esistenza da Cristo, chi si lascia scavare l’anima dalle lacrime dei poveri, chi interpreta la vita come dono e nella vita decide di operare secondo giustizia, perseguendo la pace, salvaguardando il Creato.”
Allora Missione è essere mandati, ma dove? verso chi? ... e con quali intenti?
Don Tonino ci ricorda di “camminare insieme” cambiando la frase in “insieme per camminare”. Spesso infatti ognuno esegue il proprio spartito alla perfezione, ma i suoni si accavallano senza comporsi mai nell’armonia del concerto: diamo prove di bravura personale, ma non di organicità collettiva. Ecco allora la necessità di questo stare insieme per poter camminare.
1.5.5 Padre Pancrazio, fondatore della FFB
Tutto nasce nella Santa Casa di Loreto, dove padre Pancrazio è stato fratello laico Cappuccino per venti anni (1946- 1967) e proprio lì nasce il germoglio e il desiderio di una novità: la Fraternità Francescana di Betania.
Padre Pancrazio è figlio spirituale di padre Pio, e incarnando nella sua vita l'eredità spirituale del santo di Pietrelcina la trasmette ai suoi figli:
- Amore per la preghiera: “da quando ho compreso che pregare è amare, tutto è invocare la presenza di Cristo tra noi che costruisce la fraternità'; alimenta il fuoco dell'amore vero che ci rende capaci di un'autentica vita fraterna.”
- Spirito di accoglienza: “nelle nostre fraternità c'è posto per tutti: famiglie, giovani, sani, malati, sacerdoti in difficoltà, .... La finalità è quella di creare delle oasi di pace, delle oasi nel deserto del mondo, in cui ogni persona può rigenerarsi nel rapporto con Dio. Le nostre case vogliono essere luoghi d'incontro con le famiglie, al fine di riscoprire la bellezza e la grandezza di questa vocazione.”
- Vita fraterna: “San Francesco diceva: il Signore mi diede dei fratelli e io aggiungo a me anche delle sorelle”. La vita fraterna ci impegna a vivere l'amore reciproco attraverso gesti concreti capaci di creare quella comunione che diventa via sicura per la santità. Essa è anche un sostegno della nostra vocazione e il nostro impegno primario di evangelizzazione, perché il nostro essere istituto di fratelli e sorelle fa di noi testimoni di comunione.
Padre Pancrazio con la Fraternità Francescana di Betania attualizza il carisma che Padre Pio ha trasmesso attraverso il seguente programma di vita:
“Non sii talmente dedito all'attività di Marta da dimenticare il silenzio di Maria, la Vergine madre che cosi ben concilia l'uno e l'altro ufficio ti siano di dolce modello e di ispirazione”.
A tale proposito Padre Pancrazio commenta: “siamo chiamati ad essere, come fraternità, non tutto Marta, non tutto Maria, ma a trovare un equilibrio tra la vita di preghiera e il lavoro quotidiano; questa armonia è possibile guardando la Vergine Madre, che cosi bene concilia i due uffici. La santità consiste nell'equilibrio (…) La nostra fraternità non è statica ma dinamica, è in divenire, ci aspetta sempre qualcosa in più, qualcosa di nuovo... l'uomo sogna, Dio realizza”.
2. Missionarietà nella vita dell'oblato
La missione dell'oblato consiste in un modo di essere conforme agli insegnamenti di Gesù, per cui ci si rapporta agli altri così come si è, soprattutto con la propria interiorità, ma con la massima coerenza nel proprio comportamento basato sulla umiltà e non sulla ricerca della visibilità.
L'oblato, nella Fraternità Francescana di Betania, è un fedele che decide di donarsi in maniera particolare a Dio, sull'esempio di Gesù e in Gesù, che è la vera oblazione al Padre attraverso la quale vengono cancellati i nostri peccati aprendoci la strada della perfezione nell'amore. Questo dono di sé, in concreto, si realizza nella profonda attenzione caritatevole verso i fratelli, specialmente verso quelli che il Signore ci ha messo accanto.
Nello spirito di Betania questo anelito all'amore si realizza nella vita fraterna e nell'accoglienza. L'impegno dell'oblato verso i fratelli deve essere concreto, deve realizzarsi nel bisogno reale, sia esso materiale sia spirituale, nelle circostanze precise del proprio vivere quotidiano, nel martirio della monotonia dei piccoli gesti, nella fatica della ripetizione, del perdono rinnovato, nel saper amare lì dove è più difficile, ma più vero e fonte di libertà. L’accoglienza nella vita dell’oblato è prima di tutto accogliere Dio nella propria vita. Con questa forza è possibile aprirsi agli altri.
Da quanto detto, si può far derivare l’ambito in cui l'oblato esprime la sua vocazione: la missione. Il primo momento della missione dell'oblato è la testimonianza dell'Amore vissuto nella propria vita, della bellezza di vivere concretamente la carità, del potere trasformante che la redenzione di Cristo ha sull'esistenza umana.
Il secondo momento della missione dell'oblato è quello che riguarda l'accoglienza di tutti quei fratelli che il Signore mette sul proprio cammino. L'accoglienza è la missione quotidiana dell'oblato, l'oblato è chiamato a portare pace, unità, e gioia nel suo contesto di vita, nella società, nella Chiesa, a rendere testimonianza della propria fede, ad accettare per se stesso il principio del chicco di grano che deve morire per portare molto frutto.
Gesù ci vuole, a maggior ragione da oblati, come suoi discepoli, sale della terra e luce del mondo (Mt 5, 13-14) e lo Spirito Santo, che è l’anima della Chiesa tutta, ci sostiene in questa missione. Siamo quindi tutti insieme missionari.
Noi come oblati della FFB partecipiamo, possibilmente ogni giorno, all’Eucarestia, alle varie forme di preghiera (s. Rosario, lodi, vespri e preghiera di lode) ma ci impegniamo anche a vivere e a portare nel mondo quanto ci insegna la vita comunitaria e fraterna della stessa Fraternità; ci impegniamo inoltre a rispettare i vincoli di amore fraterno tra noi, ad iniziare dalle persone più vicine che il Signore ci ha posto accanto; siamo corresponsabili insieme con i religiosi della missione della Chiesa.
Gli oblati a partire dagli impegni di famiglia, di lavoro, di cittadini e di battezzati, partecipano alla vocazione e missione della Fraternità, unendo nella vita il primato della preghiera, alla chiamata della fraternità e alla missione dell’accoglienza nella gioia, nella semplicità e nella scelta della minorità.
La Missione non è fare delle cose ma consiste nell’essere.
P. Pancrazio ci ha sempre ricordato che non è più il tempo dei maestri, ma dei testimoni, non è più credibile la testimonianza del singolo, ma la testimonianza del gruppo, della comunità, della fraternità. Più volte P. Pancrazio ci ha raccomandato di meditare il testo del discorso di Gesù all’ultima cena, più volte ci ha parlato e raccomandato l’unità fra noi. La cosa più importante che dobbiamo portare a tutti è l’incontro con Gesù. Tre sono le caratteristiche che dobbiamo acquisire: farci servi, amare perdendo tutto per amore e perdonare. Ecco che allora fraternità, missione e misericordia sono tutt’uno. E’ necessario mettersi alla scuola di Maria, come prima e vera missionaria.
Padre Pancrazio ha sempre desiderato, e desidera, che le relazioni fraterne siano improntate al calore di famiglia, atmosfera cordiale e serena, spontaneità e verità nelle manifestazioni. Non c’è spazio per gelosie e confronti, l’amore di Dio sarà grande in noi nella misura in cui lo lasceremo vivere, prendendoci cura dei nostri fratelli e delle nostre sorelle.
2.1. Missione e Vita Fraterna
La vita fraterna con le sue caratteristiche ci riporta all’ordine perché ci cala nell’ordinarietà e nella concretezza del vissuto quotidiano, ridimensionando così eventuali progetti spesso lontani nel tempo e nello spazio. La fraternità evangelica francescana si ispira infatti dalle parole di Gesù e al suo richiamo all’unità: “Che tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una sola cosa come noi siamo una sola cosa. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me” (Gv 17, 21-23).
Battezzati, assumiamo la dignità di figli di Dio e quindi diveniamo fratelli in Cristo. Questo essere suoi figli ci unifica a Lui in un particolare rapporto di vicinanza che diventa luogo di incontro con Dio. Possiamo allora essere fratelli in Cristo Gesù e uniti a Lui e non essere uniti tra noi? Missione, dunque, significa essere missionario prima di tutto con chi ci sta accanto: iniziando ad essere costruttori di unità proprio a partire dalla nostra Fraternità possiamo poi imparare a realizzare relazioni fraterne in tutti i nostri rapporti.
2.2. Missione e Accoglienza
Soltanto ponendo Gesù come fondamento della nostra vita potremo avvicinarci alla relazione con l’altro con uno spirito di carità e, dunque, di accoglienza. Essere accoglienti ci rende capaci di realizzare con semplicità e gioia, realtà umane dove ogni membro si senta accettato e voluto nonostante le reciproche diversità e dove queste diventano occasione di arricchimento e di complementarietà. “Accoglietevi gli uni gli altri, come Cristo accolse voi per la gloria di Dio” (Rm 15,7). Saremo davvero “missionari” nella misura in cui non ci demotiverà la monotona e ripetitiva sequenza degli errori nostri e di chi ci è vicino perché, riconoscendoci peccatori perdonati dall’infinita misericordia del Padre, sapremo dapprima essere tolleranti e poi aperti noi stessi al perdono con spirito di compassione. Se questo nostro comportamento “accogliente” sarà autentico specchio dell’anima allora saremo capaci di impegnarci con amore lì dove il Signore ci chiama e con chi ci fa incontrare, e non più soltanto dove e con chi vorremmo essere noi. Solo con l’impegno a riconoscere “che ogni uomo è degno d’amore, prima di ogni sua capacità e al di là dei suoi difetti, perché creatura amata da Dio e salvata da Cristo a prezzo del suo sangue” (P. Pancrazio), possiamo imparare a contribuire davvero anche alla vita di realtà complesse come la nostra Fraternità.
2.3. Missione e Preghiera
La nostra Missione, ovviamente, si alimenta dal grande fuoco della Preghiera. Un impegno che va accolto non come un dovere da adempiere passivamente ma come una reale necessità dell’anima, una sincera espressione della volontà di incontrare Cristo Gesù e costruire con Lui un profondo rapporto dialogico. Anche tutti i santi hanno testimoniato l’importanza della preghiera nella loro vita e molti hanno proposto diverse modalità per praticarla. Noi, attraverso la riflessione sulla Betania evangelica, abbiamo delineato il concetto di preghiera e i modelli di riferimento per la nostra vita di orazione.
- Maria di Betania: seduta ai piedi del Signore, ci ricorda di scegliere ogni giorno la parte migliore per mezzo della vita di orazione (Lc 10,4-19);
- Lazzaro, il risorto: testimonia che attraverso l’amicizia con il Cristo inizia una vita nuova e ci addita l’inscindibile relazione causa – effetto tra preghiera e vita vissuta;
- Marta: è segno dell’accoglienza, ma ci rammenta di non anteporre l’azione né separarla mai dalla preghiera, pena l’affannarsi in attività iniziate in nome di Dio, ma compiute effettivamente senza pensare a lui (Catechesi FFB).
Così anche il nostro agire non può non partire che dall’affidamento delle nostre azioni al Padre. Riconoscendoci poveri e limitati nelle nostre capacità chiediamo soccorso a Maria e a San Giuseppe che ci sostengono con il loro esempio di fede, umiltà e santità. Pregare con le stesse modalità e gli stessi ritmi della nostra Fraternità, per quanto compatibile con i nostri impegni di vita, rende possibile soddisfare il nostro desiderio di intimità con il Signore, rendendoci capaci di veri e concreti rapporti d’amore.
3. Conclusioni
“Questo, miei cari, è il mirabile disegno dell’opera di Dio, per cui non esistono offerte di serie A e altre di serie B, ma tutti siamo collaboratori di quell’Unico Spirito che ci ha chiamati ad unirci sotto le ali di questo carisma condiviso da tutti noi. Camminando insieme sulle strade di questo carisma che la Provvidenza Divina ci ha donato, vogliamo lasciarci santificare dall’amore sconfinato di Dio, diventando insieme testimoni veri e credibili dell’infinita misericordia di Dio per noi. A lode e gloria di Dio Altissimo e onnipotente e del Figlio Suo e nostro Signore Gesù Cristo”
(P. Pancrazio, Loreto, 30.04.2007).